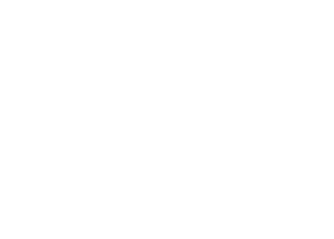L’EDITORIALE di Luigi Cignoni
L’EDITORIALE di Luigi Cignoni
Onore ai militari italiani caduti a Kabul.
Le salme dei sei parà sono rientrate oggi in Italia e domani, lunedì 21 settembre, funerali di Stato e lutto nazionale, con bandiere nei luoghi pubblici a mezz’asta.
Siamo in guerra, dunque, anche se ci ostinavamo a pensare che così non sia; abbiamo un contingente militare in una zona “calda” del Pianeta, e come succede spesso quando si è in guerra (ma questa davvero è una strana guerra che si trascina oramai da otto anni e che ha tuta l’aria di continuare contro un nemico subdolo, indecifrabile, che nel corso degli ani ha spesso cambiato casacca e che continuamente si sposta da una parte all’altra dell’Afghanistan), ci sono dei morti sul terreno di scontro.
Oggi e domani saranno i giorni in cui gli Italiani prenderanno coscienza del fatto di trovarsi in guerra; di combattere anche loro a fianco degli alleati una guerra che si trascina sanguinosamente nel tempo e di cui (francamente) non intravediamo la fine. E in guerra si è giornalmente a contatto con la morte.
Si può ben dire che i principi che ci animano sono sacrosanti e condivisi dalla parte cosiddetta buona del mondo (lotta al terrorismo, lotta a qualsiasi forma di dittatura e affermazione della Democrazia) , ma in questo caso, a lasciarci la pelle sono gli stessi individui (o le persone che appartengono alla stessa classe sociale) dei primi militari che partirono richiamati al fronte dal Re nella prima guerra mondiale e sui quali l’allora partito socialista ebbe a presentare in Parlamento una mozione con la quale condannava i quadri dell’esercito italiano che “mandava al macello” i contadini, i braccianti, proletari del sud destinati a morire per la Patria.
Chi è andato oggi a Kabul appartiene a questo sostrato sociale. Volontariamente, c’è andato mi direbbero i meglio informati. D’accordo. Libera scelta, ma per quale tornaconto. Per mettere da parte un gruzzoletto, per far fronte alle necessità e ai problemi contingenti delle famiglie italiane (la casa da finire di comprare, il mutuo da ripianare e così via). E risponde lo Stato: alle famiglie dei caduti spetterà qualcosa come dieci volte la paga di un anno dei soldati; ancora questione di soldi. Ancora con i soldi per ripianare le questioni.
La vita di un soldato, dunque, varrebbe (o equivarrebbe) dieci volte la paga attribuita.
Un’assurdità. Non c’è un valore che può reggere il confronto con la vita di un uomo, sia pure soldato, quindi a un passo dalla morte.
Così, accanto a questa constatazione, emerge un’altra riflessione: fino a quando ci ostineremo a pensare che i soldati possano “portare” la pace in un qualsiasi scacchiere infuocato del mondo? La pace non è figlia della guerra, se a essa non si coniuga con altri principi etici, universali basati sulla fratellanza dei popoli, del riconoscimento delle diversità, del dialogo fra i popoli o le etnie, le tribù.
Se non c’è poi la volontà (condivisa) di andare nella direzione di risolvere le controversie. Il presidente Obama ha un compito delicato da affrontare: quello di rivisitare e correggere le vecchie impostazioni americane, nel tentativo di venire a capo della questione afghana (passata come simbolo della lotta al terrorismo internazionale) e di evitare (ma qualcosa avrà pure insegnato il Vietnam) le trappole in cui cadde l’esercito più organizzato del mondo –quello statunitense- quando si mise in testa di intervenire in una guerra (che aveva i connotati di una guerra civile nel sudest asiatico) che non sentiva “sua”.
E l’Italia?
Cosa ci incastra in questo conflitto?
La stessa motivazione che sorresse il presidente del consiglio Cavour nel 1855 quando spedì sul mare Nero 18 mila soldati in Crimea: sedersi al tavolo della Grandi Potenze.
L’Italia, dunque ora come allora, nel novero delle Grandi Potenze mondiali. Ma per ottenere questo obiettivo, perché c’è bisogno ancora di sangue umano? Si può vincere e ottenere lo stesso risultato, senza sacrifici umani. Senza immolare all’altare del dio pagano la propria figlia, come Agamennone di ritorno dalla guerra di Troia.
Inchiniamoci davanti alle bare ricoperte dal tricolore. Rispettiamo il dolore delle famiglie.
Ma diamo anche impulso a una rivisitazione del nostro appartenere alla Nato: spingiamo nel promuovere la Pace nel mondo con la forza della Ragione, anziché con le canne dei fucili, come cantava una canzone sessantottina.