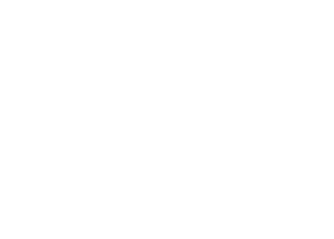Giuseppe Conte non ha mai amato le mezze misure. Il suo nuovo li brodi poesie, Non finirò di scrivere sul mare
(Mondadori), ci viene dunque incontro come una riconferma. Fin dal titolo suona infatti come un attestato di fedeltà a sé stesso e al proprio interlocutore elettivo, il mare appunto, e insieme come una rivendicazione di libertà, che poi è quella di seguire, costi quel che costi, la strada assai poco frequentata che ormai da qualche decennio ha scelto per la propria poesia.
Era da parecchio tempo che non faceva sentire la sua voce. Il libro di versi precedente, Ferite e rifioriture, è del 2006. Nel frattempo ha tradotto, continuato a scrivere romanzi, soprattutto vissuto. L’unica tappa intermedia è stata nel 2015 la pubblicazione della sua opera poetica, Poesie
1983-2015 (Oscar Mondadori), dove figurava già qualche inedito confluito poi nella raccolta presente. Introducendo quel volume, Giorgio Ficara rimarcava proprio la situazione singolare di Conte, perché questo poeta che spesso e volentieri canta a vele spiegate, fedele a un’idea di poesia e della funzione del poeta che sembrerebbe non intaccata dai sospetti, dalle reticenze e dalle diminuzioni tipicamente novecentesche, volente o nolente porta comunque con sé un sistema di relazioni oppositive e di contrasti che ne segnano la piena appartenenza al proprio tempo. «Come scrivere fuori del Novecento», notava allora Ficara, «come dire la verità su un albero, sul mare, sull’intimo abisso di noi stessi, orfani dei nostri padri dissuasori, liberi dalla loro influenza ma anche impoveriti dalla mancanza di questa loro influenza?».