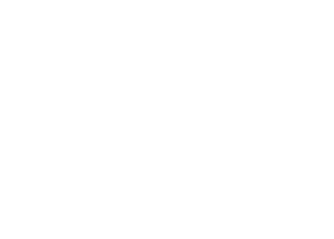Fermo dedica a Mario
Dondero, che qui ha trascorso gli ultimi anni dopo un’esistenza a raccontare il mondo che cambia, una mostra e un terminal (sì, proprio una stazione di pullman: luogo tra i più adatti per un fotografo). Lo ricorda uno scrittore che gli fu amico
La prima volta che ho incrociato Mario Dondero è quando da ragazzo ho letto La vita agra, il romanzo di Luciano Bianciardi. Dentro quel clima, nella Milano in bianco e nero del boom economico, nasceva la sua leggenda legata al Bar Jamaica e a una Brera di artisti irripetibili e molto trasgressivi, alcuni autodistruttivi e ribelli, primo tra tutti il funambolico Piero Manzoni.
Lì iniziò il suo lungo viaggio di viaggi — inseguendo il mito di quello che è stato il suo faro estetico e politico, il «fotografo zingaresco» Robert Capa, come lo definiva — che oggi è un archivio sterminato di oltre 500 mila scatti, tra bianco e nero e colore, custodito nella Fototeca di Fermo, città dove ha vissuto gli ultimi anni e dove adesso l’amministrazione comunale gli dedica il Terminal Mario Dondero, uno spazio espositivo per il contemporaneo, ma anche stazione di sosta di corriere che da qui partono cariche di viaggiatori, con l’apertura della mostra (dal 21 dicembre al 1° marzo 2020) Le foto ritrovate. Inediti dall’archivio della vita.
Sono alcuni dei tanti mondi esplorati con irrequietezza nomade da un fotografo naturale, tanto poco attratto dalla leziosità formale, dalla fotografia estetizzante, quanto onnivoro di umanistica tensione verso la commedia umana, un curioso degli altri attirato dai miti artistici e politici, del mondo del lavoro e della politica e dello sport, da Sartre a Fidel Castro, da Beckett a Charlie Chaplin, come da semplici contadini turchi, maestre irlandesi in bicicletta, operai della Fiat o della Renault, artisti di strada. Il suo amico Francesco Biamonti, lo scrittore einaudiano dei passeur, che frequentava nel suo ritiro a San Biagio della Cima, dove coltivava mimose, scrisse di lui un ritratto fulminante che ne sviscera la postura esistenziale: «Si è messo in testa di avere un forte, definitivo appuntamento con l’angelo della storia, e corre qua e là a cercarlo, tra macchine fotografiche logore, consumate, appese alla spalla. Dall’Africa salta in Siberia, e poi te lo ritrovi a Parigi, in Liguria, di ritorno da qualche altra parte».
Chi con me l’ha conosciuto e ha avuto il privilegio di lavorarci, sa quanto era
forte e caparbia questa inafferrabilità, che era il suo modo di vivere. Quella cosa che Bruce Chatwin chiamava «l’alternativa nomade» lo possedeva come un demone e lo spingeva continuamente a partire, o a tornare in luoghi dove era già stato, per fare quella che chiamava «l’arte dell’avvicinamento», una lenta messa a fuoco di un reportage che poteva durare mesi, oppure anni, come la sua ossessione storica per la Guerra di Spagna e la celebre foto cult del miliziano di Capa.
Molte tra le settanta fotografie di questa mostra marchigiana sono riemerse dalla «scatola nera» dell’archivio, come quelle scattate in Irlanda nel 1968 al seguito di Bernadette Devlin, leader cattolica irlandese, nella sua campagna a sostegno dei diritti degli studenti della Queen’s University.
In ogni viaggio, in ogni servizio, Mario
Dondero era solito e in modo prestabilito distrarsi, attratto dai movimenti minimi «della vita che scorre», così chiamava quegli attimi miracolosi e unici fermati nei suoi scatti, come il clima fumoso e complice del pub, le due donne grassocce e infagottate ferme a parlare sul ciglio della strada o i ragazzini colti in flagrante prima di un gioco pericoloso, o di una piccola trasgressione. Ma questo distrarsi necessario non significava distogliere lo sguardo dal suo racconto vivente, ma anzi allargare alla meccanica sociale, serviva a dare più forza di racconto a quel fuoco centrale che era la rivolta dei giovani che aveva già fotografato in Francia nelle leggendarie istantanee dei manifestanti a Parigi in rue Gay Lussac, o nelle aule affollatissime di corpi della Sorbona, che ora era arrivata anche a Belfast, nella nebbiosa e cruda Irlanda.
Ogni sezione della mostra, dove sono raccontati anche la scuola, nelle diverse latitudini e condizioni, e il mondo del teatro — il Tanztheater di Pina Bausch e la La Comédie Italienne di Parigi, tra gli altri — si apre con una frase, un pensiero di Mario, come quella inedita sulle Borse valori, fotografie scattate negli anni Sessanta in quelle di Atene, Parigi e Stoccolma, il teatro mimico e gestuale di uomini incravattati e in grigio nei templi del danaro, gli agenti di cambio «alle grida» e il linguaggio di un mondo che Mario guardava con spietata e saggia severità: «Oggi non vedo grandi illuminati nel mondo del capitale o della finanza. Mi sembra un universo di furbi, gente senza visioni, né pietà. Il lucro fine a sé stesso mi sembra un cattivo consigliere in qualsiasi attività umana».
Dondero ha molto fotografato anche gli artisti, i pittori e i disegnatori, a cominciare dagli inizi sull’asse culturale Milano-Roma in anni di grandi combustioni creative, molti sono stati suoi amici, come Pino Pascali, ritratto nel suo studio, Flavio Costantini o Giulio Turcato. «Nelle foto degli scrittori, più in generale degli artisti, il mio obiettivo è sempre stato quello di immortalare il talento dovunque si trovasse, con una preferenza maggiore per ciò che consideravo un bene culturale comune, per l’opera di autori che facessero crescere la civiltà, che ci raccontassero quello che spesso non si racconta», avverte il fotografo.
Sono studi spesso rabbuiati ingorgati di tele, pennelli, scatole di matite, barattoli di vernici, mondi creativi disordinati, come quello dove Tullio Pericoli guarda stupito la tela con uno dei suoi paesaggi fissata sul cavalletto, mirandone leopardianamente le eccentriche forme spaziali, la fisicità statuaria di Emilio Tadini, o la foto collettiva del 1960 nello studio di Roberto Crippa a Milano durante il lavoro su Grande quadro antifascista collet
tivo, con Jean-Jacques Lebel, Valerio Adami, Tancredi Parmeggiani e Alain Jouffroy. Sul campo — dove l’empatia degli scatti fotografici, quello che Mario chiamava «il collante delle relazioni umane», diventava decisiva — Dondero forzava ogni regola, penetrava ogni luogo e ogni cuore («era un folletto», mi disse una volta Giovina Volponi, la moglie di Paolo) e i viaggi con lui si trasformavano in vere avventure. Come quando un giorno a Monfalcone, era l’autunno del 2004, stavamo raccontando i lavoratori morti per amianto ai cantieri navali, i costruttori delle grandi star del mare, le navi da crociera monumentali, intervistando le vedove, mi chiese di scrivere il testo che avrebbe accompagnato le sue foto, un momento per me indimenticabile, o quando vagammo dentro una bufera di neve a Colle San Marco, sopra Ascoli Piceno, alla ricerca delle tombe dei partigiani trucidati dai nazifascisti.
Altre occasioni furono una via crucis fenogliana ad Alba, nel Piemonte profondo, il racconto di Cartoceto con in mente un prototipo, Un paese di Strand e Zavattini, quello di Giuseppe Di Vittorio nelle terre del Tavoliere pugliese, le in
cursioni, come le chiamava lui, nel porto di Ravenna, le puntatine che facemmo a Milano o a Ventotene.
Alla fine di quei viaggi fatti di tanti improvvisi deragliamenti, e delle sue capricciose ma necessarie curiosità, e dove la vita grazie a lui accelerava, era fatta di un altro tempo, c’era sempre una trattoria ad accoglierci, il conio popolare di un luogo comunitario dove poter mangiare, bere, ma soprattutto raccontare, raccontare storie, la nostra comune passione.
Tra le sue geografie l’Africa, cuore di tenebra del mondo e luogo magico della vita, dove ha anche realizzato un documentario sulla casta dei griots, è quella che per Dondero ha un’estensione affettiva maggiore, credo legata non solo alle guerre di liberazione, ai conflitti sociali, alla storia e ai destini, ma soprattutto alla vita dei popoli, e in questa mostra ha una parte straordinariamente toccante.
Il bianco e nero di questi scatti è sempre caldo ma severo, privo di orpelli; ha un conio inimitabile e classico. Il sentimento che domina in queste donne, uomini e bambini è l’allegria, nei momenti di svago e di gioco, ma anche nelle condizioni più difficili del lavoro rituale, lungo le rive dei fiumi, nei mercati, le strade polverose di città o quando improvvisamente parte un treno, c’è la condizione umana colta nei suoi movimenti più semplici e quotidiani, «la vita che scorre per tutti», la quale per Mario era curiosità e pura empatia, perché in quella degli altri scorreva avventurosamente anche la sua in un altro tempo che, come ha scritto Kapuscinski di quello africano, è di «una categoria molto più flessibile, aperta, elastica, soggettiva. È l’uomo che influisce sulla forma, sul corso e sul ritmo del tempo. Il tempo è addirittura qualcosa che l’uomo può creare».
Una nozione antropologica forte, diametralmente opposta a quella dell’uomo europeo che è al servizio e schiavo del tempo e della sua alienazione, la condizione necessaria per un fotografo libertario diventato una leggenda che ha vissuto la sua vita ad alta tensione. Credo che questo sia stato in un uomo come lui un elemento d’attrazione fortissimo.
ANGELO FERRACUTI, da Lettura, Corriere della Sera