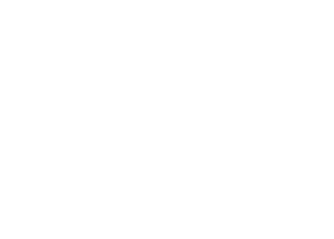Sessant’anni fa decideva di andarsene Ernest Hemingway: come lo definisce con sarcastica ammirazione l’aspirante romanziere Fitzsimmons nel film di Francis Ford Coppola “Peggy Sue si è sposata” (1986), «il perfetto scrittore americano: grasso, violento e ubriacone». Non la frase migliore per ricordarlo, probabilmente: ma inappropriata almeno al pari degli incensamenti e delle glorificazioni ricevute a (fine) vita e nei decenni a venire. Come prova il riluttante ritiro, tramite l’ambasciatore americano, del Nobel per la letteratura nel 1954 (pare abbia commentato «Troppo tardi»), Hemingway non era uno di quegli artisti che escono bene da una monumentalizzazione, così come un suo modello, di esistenza più che di letteratura, Gabriele d’Annunzio: entrambi museificati oltre ogni tollerabilità, fin nelle loro case (quella di Hemingway è a tutt’oggi la principale attrazione delle Key West in Florida). Del poeta di Pescara, Hemingway rifiutò lo stile, in nome di una semplicità calibratissima. Ma ne riprese una condotta contraddittoria, estetizzante e vitalistica: ne facevano parte il combattimento e la sfida estrema come banchi di prova del sé; le continue avventure fra Europa, Africa e America, per desiderio ansiogeno di riempire il vuoto, quando i viaggi esotici alla ricerca di luoghi autentici e del vero sé non erano ancora di massa; l’inseguimento della grande storia del Novecento, con l’ansia veloce della scrittura di giornale e il distacco della letteratura. Non c’è evento della prima metà del secolo che sia sfuggito alla sua penna – e alla sua vita: dalla Prima guerra mondiale (che affrontò da volontario, guidando l’ambulanza per la Croce Rossa sul fronte italo-austriaco, e di cui scrisse nel romanzo “Addio alle armi” del 1929), alla Guerra civile spagnola, senza tralasciare l’America del proibizionismo (come nel più antologizzato dei suoi racconti, “I sicari”, uscito nel 1927 per “Scribner’s Magazine”). Cosa sappiamo di Hemingway, la cui vita inimitabile stinge talmente sulla scrittura che previene spesso dal leggerlo, e cos’è che crediamo di sapere?
LORENZO MARCHESE, Il Tirreno, Livorno