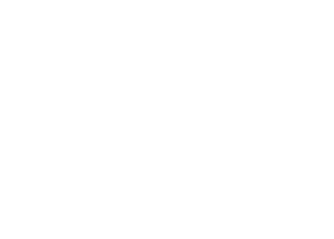Esiste una strada più silenziosa di molte altre: si trova a Baku, capitale della Repubblica presidenziale dell’Azerbaijan, ed è conosciuta con il nome significativo di Shehidler Khiyabani(tradotto letteralmente, “Strada dei Martiri”,ndr). La particolarità dellaShehidler Khiyabani– situata in cima a una piccola collina affacciata sul Mar Caspio nella zona a sud della metropoli caucasica – non è confinabile (o almeno non soltanto) entro i limiti dell’oggettivo valore estetico che il suo panorama offre quotidianamente a cittadini azeri e non. La natura insolita del luogo trova invece la sua ragion d’essere in un paradosso che la rende diversa da qualsiasi altra strada esistente al mondo: la sua funzionalità non è mettere in comunicazione luoghi, cose o persone, ma consentire il dialogo tra passato e presente. La Strada dei Martiri è una strada “del tempo” e vi si viaggia grazie al solo mezzo di trasporto che permetta all’uomo di camminare sulle proprie gambe: l’esperienza, sinonimo più neutro e meno compromettente del termine “memoria”.
La Shehidler Khiyabaniè una strada, ma è anche un cimitero memoriale dedicato all’eroismo civile, al sangue versato e all’identità di nazione di un popolo, vale a dire la traduzione in valori umani, pedagogici e consolatori di una Storia ciclicamente violenta e, perciò, incontrovertibile. Sono questi i valori positivi che, nell’alternarsi degli eventi e delle forze in gioco, sfondano il recinto dell’opinione e al di là di tutto “restano” ad accarezzare le trame dell’ingiustizia, creano una “memoria” e cicatrizzano parzialmente le ferite inflitte alla coscienza di un popolo. È, infatti, nel nome della memoria e della storia, che ogni anno gli azeri, siano essi funzionari governativi, diplomatici stranieri o semplici cittadini, si riuniscono nella giornata del 20 gennaio, data di lutto nazionale, per commemorare le vittime dei drammatici avvenimenti di Baku, maturati nei torridi anni dellaperestroijka, ed esplosi nelle primissime settimane dell’anno 1990 – il famoso periodo passato alla storia con la triste etichetta di “Gennaio nero”.
I fatti del gennaio 1990 meritano, proprio per la loro gravità, un’attenta contestualizzazione che chiarisca ruoli e posizioni della parti che si confrontarono. “Gennaio nero” è la sigla scelta dalla storiografia (ancora oggi troppo taciturna a proposito dell’area transcaucasica) per dar nome a un massacro, e che va tuttavia impaginata in un libro più grande, quello di un conflitto su scala ben più ampia: il conflitto mai del tutto risolto del Nagorno-Karabakh.
Il Nagorno-Karabakh è una regione montuosa a sud-ovest dell’Azerbaijan; si tratta di un’enclave dello stato azero, la cui popolazione a maggioranza etnica armena ha vissuto per decenni, quasi un secolo se si adotta il 1917 cometerminus a quo, seri problemi di convivenza con la minoranza azera stanziata sullo stesso territorio. Il clima di tensione instauratosi dopo il collasso dell’Impero russo ha posto la regione in un’impassedi insofferenza, esponendola alla costante minaccia di nuove recrudescenze: in prima istanza si è sempre assistito, per ragioni evidenti, al periodico riaffiorare del dibattito sul tema della potestà territoriale, insieme al conseguente rinfocolarsi di moti separatisti a seconda dell’inasprimento o della distensione dei rapporti bilaterali tra le attuali (autonome entrambe dal 1991) repubbliche, d’Armenia (che per ovvi motivi pendeva verso la causa separatista) e quella, appunto, dell’Azerbaijan.
Il 1985 è un anno fondamentale per ricostruire le premesse politiche che portarono al Gennaio Nero: nel marzo dello stesso anno il PCUS elegge un nuovo Segretario Generale nella persona di Michail Gorbaciov, il futuro campione dellaperestroijka, nonchè Nobel per la pace nel 1989.
È proprio nei complicati anni della sua azione politica che in Nagorno-Karabakh torna d’attualità il desiderio di autonomia – per la prima volta, un’ambizione simile sembrò realizzabile – grazie allo spirito di cambiamento promosso e promesso dalla ventata riformistica scatenata dal leader comunista. Il 20 febbraio 1989, tra le strade della capitale armena Erevan, le rivendicazioni dei manifestanti si fanno sentire sotto forma di nuovi cortei, la cui affluenza è imprevedibilmente cospicua e, già dopo due giorni, non tarda ad arrivare il primo fatto di sangue: in uno scontro nei pressi di Askeran, all’interno del territorio del Nagorno-Karabakh restano uccisi due giovani azeri. L’episodio, propriamente interpretato comecasus bellida più parti, inaugurava un’inauditaescalationdi violenze, il cui unico obiettivo era quello di provvedere a una risolutiva “pulizia etnica” ; la strada verso l’autodeterminazione dei popoli virava dunque nella direzione forzosa delpogrom. La riapertura delle ostilità ebbe un prezzo molto alto in termini di vite umane, per entrambe le parti in conflitto. Nell’autunno 1989 gli azeri piansero di fronte alle tremende stragi di Kafan, Spitak, Gugark, Vardenis, Ijevan, Noyemberian, Megri, Krasnoselsk e di altre 19 province della Repubblica armena. I bilanci relativi al solo dicembre 1989 parlano di 216 azeri rimasti uccisi e di altri 196.000 profughi in fuga dall’Armenia che tentarono di raggiungere l’Azerbaijan attraverso le montagne. A loro volta gli armeni residenti in Azerbaijan furono espulsi dall’allora RSS Azera, in particolare dalle province di Shamakha, Ismailly e Geranboy.
La svolta definitiva, che incanalò il sangue già versato e i nuovi malumori verso le giornate del gennaio nero, si ebbe nei primi giorni dell’anno, quando il partito dei nazionalisti radicali del Fronte Popolare azero insorse, incitando la popolazione azera ad affrontare il pericolo a viso aperto, senza più serbare alcuna speranza nella possibilità di risoluzione pacifica. Alle parole seguirono presto i fatti: la retorica anti-armena riscosse ampio consenso, e per questo motivo il 12 gennaio la popolazione si riversò in ogni angolo di Baku, fino a confluire in Piazza Lenin per una grande mobilitazione di massa voluta dal partito.
In quell’occasione il Fronte Popolare aizzò le folle contro il nemico-armeno dichiarando comune e necessario il fine della manifestazione: proteggere la propria sovranità dalle mire espansionistiche armene. È facile capire, stando a tali premesse, come l’esasperazione, liberata ormai da ogni freno, possa essere immediatamente sfociata in una carica di violenza straordinaria, che di fatto cedette il passo al disordine di una guerra senza quartiere, combattuta a tutte le ore del giorno e per un’intera settimana, mettendo a ferro e fuoco la capitale azera.
La drammaticità con cui ilpogromanti-armeno andava propagandosi spontaneamente tra le vie della città si trovò a stridere terribilmente con l’ambiguo silenzio di Mosca e dei suoi elementi di governo, i quali parvero sottovalutare le possibili conseguenze dell’incresciosa contesa territoriale. All’improvviso questo silenzio si ruppe e il fragore che ne derivò fu eccessivo.
L’imprevedibile mutò in arbitraria realtà, e tutto accadde in maniera parziale e clamorosa tra la notte del 19 e l’alba del 20 gennaio, quando, su ordine diretto del segretario generale Gorbaciov, l’Armata Rossa fece il suo ingresso a Baku, schierata in equipaggiamento pesante e con un numero di effettivi di poco inferiore alle 30 mila unità. Questo intervento pose fine solo parzialmente al già grave silenzio iniziale, perché fu stabilito e messo in atto senza che nessun canale ufficiale avesse provveduto alla preventiva proclamazione dello stato di emergenza. e si rivelò, soprattutto a causa di una simile violazione nei confronti di qualsiasi convenzione militare, clamoroso in termini di conseguenze: la forza devastante con cui il macigno sovietico si abbatté sulla città, stroncò, da una parte, l’acuirsi ulteriore delle violenze, ma, dall’altra, anche le vite di centinaia di azeri inermi e impreparati a difendersi.
Le stime alternatesi nelle settimane e nei mesi successivi non hanno mai portato a un chiarimento definitivo sull’entità del massacro di Baku; volendo provvedere a una collazione dei dati, in ogni caso imprecisa, si può con cifre generiche ricordare che circa 130-150 furono i civili azeri rimasti uccisi negli scontri, mentre il numero dei feriti potrebbe variare da un minimo di 600 a un massimo di circa 800 individui; in calce a questi dati non va inoltre trascurato che il numero dei dispersi non è nemmeno vagamente ipotizzabile. La credibilità di questi dati vacilla palesemente, considerata la precarietà della base su cui poggiano, ma se si è voluto riportarli è per restituire al lettore un’idea, sia pure imprecisa, ma quantomeno trasparente, dell’entità delle stragi di Baku.
I numeri a volte restano tali, paralizzati nella loro natura di segni, spesso ostili perché meri significanti e custodi di un significato indubitabile. I numeri esprimono le gravose complessità di una certezza. Ed è forse partendo dalle certezze, anche quando assumono la sembianza intollerabile e oscena della morte, che si deve provare a riflettere sul senso recondito del concetto di libertà. La libertà può smettere di essere un mito, e quanto più sarà emancipata dai suoi esegeti, tanto più sarà prossima a un rinnovato contatto con la realtà. È necessario comprendere il senso di un prezzo già pagato, per riuscire a percepire la sfumatura incalcolabile del suo valore, quello scarto che rende inalienabile il diritto alla libertà, in quanto prerogativa essenziale e pragmatica dell’individuo. La lezione della storia, infine, insegna che la memoria è prima di tutto esercizio critico, e quando viene a mancare tale presupposto, lo sforzo può farsi sterile e persino compromettente, perché quando si perde di vista il valore concreto dell’esperienza, e si smette di essere critici nei confronti della storia (sia propria o altrui, grande o piccola), allora si rischia di giocare al gioco insincero e poco lucido dell’astrazione. Tuttavia un pericolo del genere, non compromette affatto il lento ritorno al dialogo del popolo azero, che è tornato a parlare con la storia e i suoi principali interlocutori, e questo accade sebbene (o proprio a causa di questo) l’unica coscienza rimasta nel loro cuore sia quella del dolore e delle lacrime che ancora oggi, a distanza di 26 anni, bagnano il marmo delle lapidi esposte lungo la Strada dei Martiri, un marmo nero come il cupo sentimento del lutto, nero come quel triste giorno di gennaio che sarà in eterno ricordato dalla Storia come il 20 gennaio 1990, il “Gennaio Nero” di Baku.
LaShehidler Khiyabaniè forse una strada più silenziosa di molte altre, ma allo stesso tempo è una strada che vive, forse più di molte altre.
Antonio Saracino